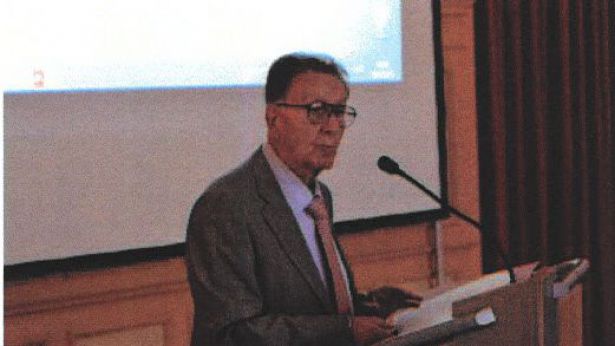Il 25 novembre si celebra la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In questa interessante e ampia intervista, il professor Guido Brunetti analizza le radici profonde dell’aggressività e della violenza, indicando alcune strategie per contrastare il complesso fenomeno. L’autore ha pubblicato molti lavori sul femminismo, la
violenza sessuale, il femminicidio e le tante anime della donna, partendo dall’inferiorità biologica fino ad arrivare ai suoi grandi talenti.
“Il mondo odierno è attraversato da una profonda crisi umana, sociale e morale, caratterizzata dal tramonto dei valori e delle antiche certezze. Già il premio Nobel K. Lorenz nel suo libro ‘ Il tramonto dell’uomo’ scriveva che le prospettive dell’umanità sono estremamente cupe”.
“C’è l’idea che il mondo sia dominato dalla violenza. E’ un tema intricato e dibattuto, che mostra dati allarmanti. E’ un problema diffuso e la violenza sulle donne da venti anni è ai massimi livelli. Il professor Giovanni Bollea, padre della Neuropsichiatria infantile in Italia e chi scrive negli anni Novanta del secolo scorso, sono stati i primi a parlare dell’esistenza nel mondo di un processo strisciante di violentizzazione.”
Così il Professor Brunetti inquadra il tema della violenza alla luce della situazione della società odierna, e definisce la parola attraverso la sua etimologia:
“La violenza e l’aggressività sono un elemento di questa storia umana. Nella sua origine latina, il termine violenza deriva da ‘vis’, forza, fa riferimento quindi alla forza legata a un’azione, un comportamento, una passione. Alcune correnti filosofiche e scientifiche la considerano parte integrante della natura umana, un elemento cioè costitutivo dell’uomo. Nasce con l’uomo.”
Il professore approfondisce l’idea della violenza intrinseca all'uomo delineando l’evoluzione di essa nel corso del tempo:
“Essa è presente nella Bibbia, dove viene usata sia come medicina nei confronti dei peccatori che per vendicare i giusti e gli innocenti. A partire dagli anni ’30 del XX secolo, le teorie dominanti sono ancorate alla psicoanalisi, ossia al concetto di pulsioni ed emozioni, frustrazione ed aggressività. Prevalgono le prospettive neurobiologiche, genetiche e naturalistiche. Viene definito aggressivo il comportamento che procura danno a qualcuno o qualcosa. Per violenza invece s’intende quella forma di aggressività che assume l’intento di arrecare danni estremi alla
vittima, potendo arrivare fino alla sua morte. Tutta la violenza è aggressività.”
Dalle sue parole, individuiamo il ruolo centrale che hanno le neuroscienze nella comprensione e nell’analisi dei meccanismi che si celano dietro gli istinti aggressivi.
“Secondo la psicoanalisi, -continua il Professore- che ha dato un’importanza crescente all’aggressività, mostrandola in relazione allo sviluppo del soggetto, alla sessualità e al concetto di pulsione di morte, essa, come il sadismo e l’odio, è una disposizione innata e naturale, una pulsione che richiede di essere scaricata. Per
Freud, essa ha anche un carattere di ‘autoaggressione’: lutto e melanconia, senso di colpa inconscio, masochismo dell’ Io. Una pulsione distruttrice e autodistruttrice, presente fin dalla prima infanzia.”
Brunetti fornisce anche una definizione del comportamento aggressivo da punti di vista diversi dalla psicoanalisi, ma strettamente correlati a essa:
“Secondo l’etologia, tale comportamento dipende da un accumulo di energia nel sistema nervoso. Secondo K. Lorenz, l’aggressività serve per preservare sia la specie che l’individuo. Gli animali sono più aggressivi con i propri conspecifici rispetto a quanto non lo siano verso altri esemplari di altre specie. Secondo la sociobiologia,
l’aggressività risponde a una funzione precisa: la conservazione e lo sviluppo della specie. Psicoanalisi, etologia e sociobiologia, pur da differenti prospettive, sono accomunate dall’idea che l’aggressività e la violenza siano
innate.”
La concezione della violenza come ossatura dell’essere umano si scontra con l’immaginario collettivo, a proposito del quale Brunetti puntualizza la visione comune:
“Noi riteniamo che il comportamento violento e aggressivo sia l’esito di una complessa interazione di fattori neurobiologici, genetici, personali, socio-ambientali e culturali.”
In realtà, la violenza ha sede nel cervello umano e nel suo funzionamento, e sono proprio le neuroscienze a confermarlo:
“Sono state soprattutto le nuove neuroscienze a studiare le basi cerebrali e biologiche della violenza e dell’aggressività, identificando disfunzioni in alcune aree del cervello, come la corteccia prefrontale, il sistema limbico e l’amigdala, che influiscono sulla sfera emotiva, l’impulsività, i neuroni specchio e l’empatia. Fattori genetici e alterazioni neurotrasmettitoriali come la serotonina, uno dei più potenti modulatori dell’umore, e la
dopamina, che è legata al controllo delle funzioni cognitive, possono predisporre a comportamenti violenti.”
Nella società attuale, la violenza si declina in una moltitudine di maniere diverse, e il Professore mette in luce una delle più degenerate:
“Esistono molteplici forme di violenza. Una delle forme più gravi è il Disturbo antisociale di personalità (DAP), che si esprime attraverso una serie di comportamenti, come la violenza fisica e psichica, il comportamento impulsivo e il bullismo.”
I cosiddetti “trigger” che mettono in moto i precedentemente citati presupposti del comportamento violento sono svariati, ma vanno ricercati nelle prime fasi di vita:
“Le origini della violenza e dell’aggressività vanno ricercate in una complessa, difficile e delicata combinazione multifattoriale.
Questi fattori possono essere favoriti già nel periodo della gestazione attraverso disturbi alla nascita ed esposizione prenatale a sostanze tossiche come l’alcol e il fumo. L’esposizione a queste sostanza è all’origine di danni neurologici rilevanti, come ritardi cognitivi, disturbi dell’apprendimento e comportamenti antisociali e
devianti. Con la nascita, è l’ambiente socio-familiare ad avere una funzione basilare. Uno dei primi studiosi, J. Bowlby, ha mostrato che la separazione precoce dalla madre o il rifiuto emotivo da parte dei genitori, forme di abbandono e violenza in età infantile possono avere conseguenze devastanti sullo sviluppo fisico e mentale del
bambino.”
Per analizzare questi processi, spiega Brunetti, gli studiosi si sono serviti del mondo animale:
“La ricerca dei meccanismi alla base della violenza è stata condotta su animali, i quali hanno contribuito in modo fondamentale sia a comprendere l’aggressività e la violenza sia ad organizzare adeguate strategie atte a ridurre questi fenomeni. Tra gli animali più utilizzati ci sono i topi, i quali esprimono un repertorio aggressivo molto sviluppato a partire dall’età di circa un mese.”
Alcuni degli studi condotti a questo proposito hanno evidenziato una maggior predisposizione degli uomini a sviluppare tendenze aggressive:
“Gli ormoni rivestono un ruolo cruciale. L’influenza del testosterone nel controllo di tali comportamenti è stato evidenziato da numerose ricerche. Gli studi poi hanno dimostrato un maggior livello di aggressività fisica e psicologica degli uomini rispetto alle donne.”
Dopo la dettagliata ed esaustiva panoramica sulla complessità di questo fenomeno e le sue fondamenta neuroscientifiche, si apre il dilemma etico legato alla questione: cosa si può fare per combattere la violenza e l’aggressività?
“La ricerca nella prevenzione risulta abbastanza carente. Sul piano farmacologico un’ampia gamma di farmaci risulta essere efficace nel ridurre il comportamento aggressivo nei bambini e negli adolescenti, nonostante vi siano poche ricerche sulla loro efficacia a lungo termine. Le neuroscienze sono alla ricerca di approfondire
e comprendere le loro cause allo scopo di realizzare interventi mirati, come il supporto prenatale, il monitoraggio delle complicazioni perinatali, l’educazione familiare, programmi educativi per le donne in gravidanza, interventi nelle scuole e nelle comunità e politiche sociali.
Sta di fatto -conclude Brunetti- che le ricerche neuroscientifiche in materia hanno importanti applicazioni e notevoli ricadute sul piano umano, sociale, economico e morale. La comprensione di questo fenomeno, che ha una dimensione universale, riveste un enorme significato sia come manifestazione di patologie neuropsichiatriche
sia come causa di questioni di natura socio-politica.”
Gaia Stivaletta